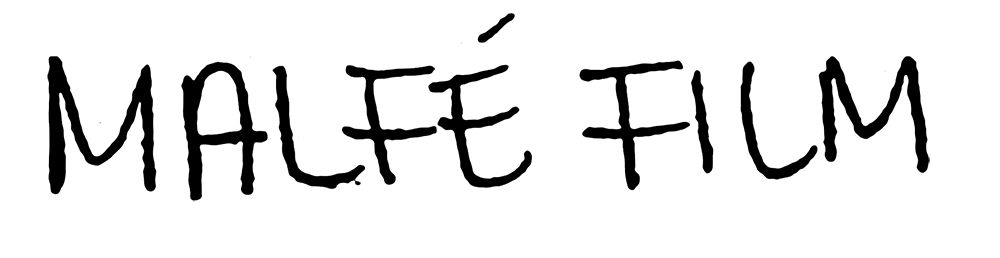Alessandro Amato, noto critico cinematografico, operatore culturale, sceneggiatore e direttore artistico dell’undicesimo TORINO UNDERGROUND FESTIVAL incontra gli autori Camilla Morino e Alberto Sparapan.
A volte capita di partire da un’immagine, un personaggio che compie un’azione, oppure una situazione generica alla quale poi si aggiungono dettagli. Come nasce l’idea per questa storia?
L’immagine del nostro confine è un luogo in cui non ci sia modo di identificare niente se non una linea che divide. Durante la scrittura, abbiamo capito che stavamo cercando semplicemente di parlare del mondo in cui viviamo, un mondo in cui si possono ancora intraprendere guerre per stabilire a chi appartiene quale fetta di mondo. Da quando abbiamo iniziato a lavorare al soggetto il mondo intero si è mosso sulla questione dei confini e le politiche legate ad essi si sono inasprite ancora di più. In qualche modo, ruota tutto attorno all’arbitrarietà, all’arrogarsi il diritto di poter scegliere a chi deve appartenere cosa. Tipo i confini degli stati americani o dell’Africa, tracciati con un righello su una cartina. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo deciso di togliere ogni riferimento geografico: volevamo che fosse tutto dichiaratamente arbitrario. Come è arbitrario il presidio, messo lì da noi apposta per il film e che prima non esisteva, per esempio. Cercavamo un luogo dove niente e nessuno avrebbe potuto modificare il corso della storia — che è completamente guidata dalle scelte dei nostri personaggi. Per un sacco di tempo non ci siamo neanche immaginati le sbarre, non c’era niente di fisico. Potevano esserci solo una sedia, un gabbiotto e un doganiere ed era lui a determinare che lì ci fosse un valico. Se dai piani alti gli avessero detto “spostati di qualche metro” lui avrebbe preso la sua sedia e, fedele alla sua divisa, si sarebbe spostato e con sé avrebbe spostato il confine che difende. Per noi era un’immagine semplice, ma potente.
“Dove non fa buio” è in lingua italiana ma non si citano mai nomi di città o Paesi. Mentre scrivevate, in relazione alle procedure di controllo e alla questione del “fondato sospetto”, vi siete documentati sulla legislazione specifica?
Sì, ci siamo documentati su entrambe le questioni e ci siamo accorti che remava tutto contro di noi (ironico). No, ovviamente non tutto. Abbiamo aperto un dialogo con diverse persone, quando narri una storia di questo tipo è fondamentale fare ricerca. Ci siamo interfacciati con chi vive la “tematica” del confine toccandola con mano: avvocati, militari, abbiamo conosciuto anche dei doganieri e parlato con coetanei che, per motivi di lavoro, attraversano valichi praticamente tutti i giorni. Proprio come i nostri personaggi, ci servivano punti di vista eterogenei sulla questione. Dialogando con loro abbiamo realizzato che la storia, per come l’avevamo immaginata noi, si scontrava molto con la realtà — dove le cose non vanno esattamente così. Ci siamo quindi accorti che non volevamo raccontare una verità assoluta ma una verità relativa, una verità coerente con i personaggi che stavamo costruendo. Abbiamo abbandonato l’idea di un mondo e un luogo specifici e abbiamo invece optato per un universo senza connotati linguistici e geografici, seguendo quella che era la verità che stavamo ricercando nel nostro film. E cioè che non è facile arbitrare la legge ovunque ci si trovi, perché esistono sempre modi di interpretarla e aggirarla.
Cosa cercavate nei tre interpreti che avrebbero portato in scena i personaggi? E cosa ritenete che abbiano aggiunto o modificato rispetto alla carta, se l’hanno fatto, coloro che avete scelto?
In scrittura i doganieri avevano età diverse. Quello più navigato e bonaccione, stanco del proprio mestiere; e quello più giovane, ligio al dovere. Pensavamo che il senso fosse creare delle differenze in superficie, ma abbiamo poi capito che, per rispondere alla nostra domanda tematica — ovvero l’arbitrarietà della Legge e dei confini — era più interessante togliere le differenze anagrafiche. Ciò che li rende diversi sono le loro caratteristiche individuali e come decidono, da esseri umani, di mettere in pratica la legge.
Tra l’altro questa è stata una motivazione in più per affidare i due ruoli a persone con cui siamo cresciuti creativamente. Qualche anno fa, mentre noi frequentavamo il corso di Regia alla Luchino Visconti, Vito e Lorenzo si stavano diplomando in Paolo Grassi. Oggi che stiamo muovendo i primi passi è molto bello farlo con persone amiche. Con chi, come noi, condivide l’urgenza di fare questo mestiere. Abbiamo potuto affidargli i nostri personaggi e lasciare che fossero loro a “riscriverli” secondo il proprio ruolo di attore.
Irene, invece, è stata una sorpresa. Il personaggio dell’avvocata lo avevamo costruito su un’altra attrice che purtroppo non ha potuto partecipare al film. Ma ci ha fatto un regalo bellissimo, farci conoscere Irene. Ha una fisicità molto diversa, un’estetica diversa, forse anche una recitazione diversa. Non è stato semplice adeguare quello che ci eravamo immaginati per così tanto tempo su una persona. Ma alla fine si è rivelata una bellissima conseguenza, perché ha dato al personaggio sfumature che nella sola scrittura non saremmo stati in grado di concepire.
Il cortometraggio è girato (quasi) interamente in piano sequenza. Comincia dal punto di vista dell’avvocata, poi quando la guardia frontaliera fa il giro intorno al veicolo seguiamo lui fino a rovesciare lo sguardo sulla donna, come un lunghissimo campo/controcampo. È sempre stata questa l’intenzione oppure è una soluzione che avete raggiunto successivamente?
A un certo punto della scrittura è inevitabile iniziare a immaginarsi visivamente il film. La cosa più caratteristica di un controllo doganale è che il tempo diventa estremamente soggettivo: quelli che sono minuti possono sembrare ore o viceversa. Ci siamo detti che un montaggio più classico — che è per definizione la manipolazione dello spazio e del tempo — non avrebbe servito a dovere la vicenda. Perché nel nostro film il tempo della storia e il tempo della narrazione coincidevano e abbiamo quindi scelto di coreografare gli attori, le loro pause, i loro movimenti, lasciandogli sempre la massima libertà.
Il cambio del punto di vista è arrivato di conseguenza. Avevamo molto chiaro il punto di vista iniziale, quello della protagonista, ma poi scrivendo abbiamo capito che limitarci a lei significava analizzare solo una parte della storia. Anche qui il pianosequenza ci è stato d’aiuto. Ci ha costretti a fare scelte molto radicali, a seguire tutti gli esseri umani che abbiamo messo in scena. Non c’è mai stata l’idea di creare un campo-controcampo, ma di lasciare piuttosto che la macchina da presa fosse una sorta di occhio che ci accompagna attraverso tutti i punti di vista della storia lasciando che siamo noi, da spettatori, a scegliere da che parte stare.
Questa particolare messa in scena dei rapporti tra i personaggi fa pensare alla volontà di mostrare i diversi aspetti di una situazione troppo complessa per essere lasciata al dovere di cronaca. Come pensate che il cinema, in qualità di linguaggio, possa contribuire alla lettura della realtà?
Il nostro obiettivo era raccontare la realtà consapevoli di star utilizzando lo strumento della finzione, perché in fondo è questo che fanno i film. Soprattutto i film che a noi piacciono, quelli in cui non riesci a stare dalla parte di qualcuno, perché la realtà che rappresentano è talmente sfaccettata, complessa e umana che nessun personaggio ha mai veramente torto o ragione. Non è quello il punto. Abbiamo concepito i personaggi ciascuno con un proprio dilemma interiore, perché era nostro dovere farlo. È stata poi l’unione di tutti i loro punti di vista a restituire la realtà per quella che è. Un po’ come mettere lo spettatore di fronte alla storia e dirgli: cosa faresti tu, da che parte stai? E soprattutto, è facile scegliere? È questo, secondo noi, il modo in cui il cinema può aiutarci a capire il mondo reale.